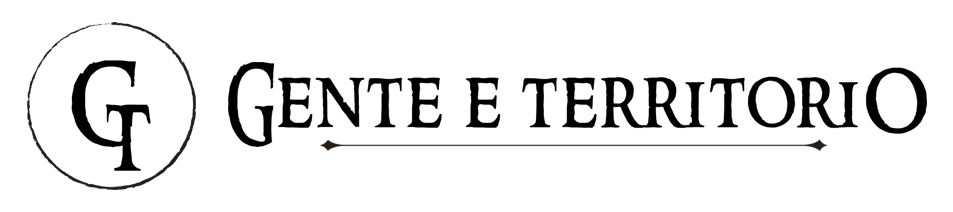“Io sono nato in Guinea, ma non in Guinea-Bissau e nemmeno in Guinea Equatoriale. C’è un’altra Guinea, quella che ha come capitale Conakry. Confina con sei Paesi…” : inizia così “Fratellino”, il racconto della vita e del viaggio verso l’Europa di Ibrahima Balde, alla ricerca di Alhassane, uno dei 144 morti in un naufragio di migranti nel Mediterraneo. Il libro è “scritto a voce da Ibrahima Balde, e a mano da Amets Arzallus Antia”. Nel maggio dello scorso anno, Papa Francesco lo distribuì ai vescovi riuniti per l’Assemblea generale della Cei.
«Se un giorno tornerò a casa, e mia madre e le mie sorelle saranno ancora là, vorrei raccontare loro tutto quello che sto raccontando a te. Perché anche loro possano capirmi almeno un po’. Perché non sanno niente. (…) Racconterò loro tutto questo. E so già cosa mi chiederanno, perché non sono tornato a casa se il mio destino non era l’Europa. (…) Ho pregato, e ho pensato: “Se Dio vuole che io arrivi in Europa, arriverò in Europa. Se non lo vuole, mi perderò nel mare”. Anch’io.
(…) Abbiamo passato tutta la notte alla deriva, in mezzo al mare. La gente ha iniziato a piangere, soprattutto le donne, ma non solo loro, anche il capitano. Era senegalese. Io non so chi l’ha nominato capo della spedizione. Aveva detto che conosceva il mare, ma un capitano ha bisogno di più forza nel cuore, deve dimostrare che è il più coraggioso, invece quello piangeva come un bambino. Così è difficile arrivare in Europa.
Io ho cercato di legare le ali al mio spirito, di non pensare più, ma non era facile. Vedevo il viso di mia madre davanti ai miei occhi. E pensavo: “Alhassane sarà partito in una notte come questa”.
Il mare è molto vasto, come la notte. Ma la notte, se aspetti un po’, ti lascia su una riva, e allora è giorno, viene la luce. Si vede di nuovo tutta la vastità del mare, e pensi, impossible.
A un certo punto, il gommone ha iniziato a perdere aria. Il capitano ci ha fatti spostare tutti da un lato e quasi il gommone si ribalta. Tutti hanno gridato, e dopo pianto. Anch’io. La paura mi era entrata fino alle ossa. Lì, per l’ultima volta, ho guardato ai quattro lati e ho visto sempre lo stesso, ho pensato: impossible.
Alcuni indossavano una guba di tela, altri una camera d’aria di bicicletta gonfiata legata a tracolla. Io non portavo niente, e quello era un ulteriore peso sulla mia coscienza. Io avevo meno speranze degli altri, ho calcolato.
Le undici zero zero. Tutto uguale.
Le dodici zero zero, e mi sono messo ad aspettare la morte. Soprattutto quando ho premuto il gommone con le dita e mi sono reso conto che non c’era più aria, che era completamente sgonfio.
Le tredici zero zero, e tutto uguale. Continuavo ad aspettare la morte.
Le quattordici zero zero, e un elicottero. Prima lo senti, poi lo vedi, alla fine ci credi. Sì, un elicottero.
A due ragazze vicino a me ho tolto la guba e ho iniziato ad agitarle in aria. A sinistra e a destra. A sinistra e a destra. Anche gli altri hanno fatto la stessa cosa. Quello era il nostro segnale. Tutte le guba danzavano sopra le nostre teste. “À l’aide, à l’aide.”
L’elicottero si è abbassato e ha cominciato a fare giri sopra di noi. L’elica faceva muovere il mare e il gommone quasi si ribalta. Stavamo tutti gridando, “à l’aide, à l’aide”.
Ci hanno visto, hanno fatto dei gesti con la mano e se ne sono andati. Allora sono crollato. Mi sono ricordato di mia madre. “Sarà là, al villaggio, cosa starà facendo?” Quando l’elicottero se n’è andato ho perso ogni speranza di uscire vivo da lì.
Dopo quaranta minuti sono tornati. Prima l’elicottero, poi una nave. Salvamento maritimo. L’ho riconosciuta dal colore, perché me l’avevano spiegato nella foresta: “La nave che verrà a salvarvi avrà il colore delle arance”. Era quella. Abbiamo iniziato tutti a gridare: “Boza! Boza! Boza!”.
Questo grido è una cosa di noi africani. Si fa quando l’avventura in mare finisce bene. “Boza! Boza! Boza!” Nella foresta di Tangeri o in quella di Nador, quando si viene a sapere che un programma è arrivato in Europa, la notizia si diffonde subito: “Ieri cento persone hanno cantato boza”.
La nave di salvataggio si è fermata vicino a noi e ci hanno lanciato una lunga corda. Prima hanno fatto salire le donne e i bambini. Noi gridavamo tutti, chiedendo il nostro turno, e dalla nave vicino ci dicevano: “Tranquille, tranquille”. Io so molte parole di francese e ho subito pensato: “Questo significa che dobbiamo stare calmi”. Allora mi sono calmato un po’.
È arrivato il mio turno. Mi hanno allungato la corda e mi hanno fatto salire sulla nave. Mi hanno dato acqua e una coperta. Ho bevuto un sorso e ho iniziato a piangere. Ho pianto come un bambino piccolo. Poi mi sono alzato in piedi e mi sono guardato attorno, per vedere da dove venivo.
Adesso lo so, il mare non è un posto dove sedersi.»
Ibrahima Balde e Amets Arzallus Antia, Fratellino, ti racconterò la mia vita.