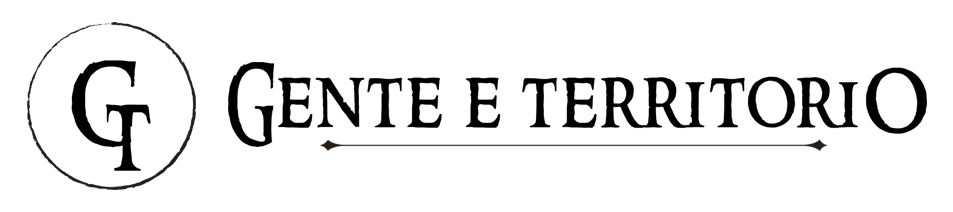Scrittrice e giornalista bielorussa, Svetlana Aleksievič è nata a Stanislav (oggi Ivano-Frankivs’k), in Ucraina, nel 1948. Nel 2015 le è stato conferito il premio Nobel per la letteratura. La citazione è tratta dal testo letto in quella occasione. “Ho tre case: la mia terra bielorussa, che è la patria di mio padre e dove ho vissuto tutta la mia vita; l’Ucraina, che è la patria di mia madre e dove sono nata; e la grande cultura russa, senza la quale non riesco a immaginarmi. Ho care tutte e tre. Ma è difficile parlare d’amore, di questi tempi”.
«Non sono sola, su questo palco… Ho intorno le voci, le centinaia di voci che sono sempre con me. Da quando ero piccola. E abitavo in campagna. A noi bambini piaceva molto giocare per strada, ma la sera erano le panche fuori dalle case (dalle chaty, come si dice da noi), quelle su cui si davano appuntamento le donne ormai stanche, ad attirarci come una calamita. Quelle donne erano tutte senza marito, senza padre, senza fratelli. A guerra finita non ricordo uomini nel mio paesino: tra il fronte e la resistenza, la seconda guerra mondiale si è portata via un bielorusso su quattro. Il nostro mondo di bambini del dopoguerra era un mondo di donne. E mi è rimasto soprattutto impresso che quelle donne parlavano d’amore, non di morte. Raccontavano di quando avevano salutato per l’ultima volta coloro che amavano, di come li avessero aspettati e li aspettassero ancora. Gli anni passavano, ma loro non smettevano di aspettarli: “Senza braccia, senza gambe, basta che torni: me lo porto in spalla”. Senza braccia… senza gambe… Credo di averlo saputo fin da bambina, cos’è l’amore.
(…) Di sé Flaubert diceva di essere un “uomo-penna”. Di me potrei dire che sono una “donna-orecchio”. Quando cammino per strada e afferro parole, frasi, esclamazioni, penso sempre a quanti romanzi scompaiono senza lasciare traccia. Svaniti nel tempo. Dissolti nelle tenebre. C’è tutta una parte della vita umana, quella del parlato, che non riusciamo a portare nella letteratura. Non l’abbiamo ancora apprezzata come si dovrebbe, non ce ne siamo fatti stupire o incantare. Io, invece, ne sono ammaliata e prigioniera.
Amo il modo di parlare di ogni persona… Amo le voci solitarie. È il mio amore più grande, la mia passione.
La strada per arrivare a questo palco è stata lunga: ci ho messo quasi quarant’anni. Un essere umano dopo l’altro, una voce dopo l’altra. Non posso dire che sia sempre stata facile da affrontare, questa mia strada: gli esseri umani mi hanno scioccata e spaventata, hanno suscitato in me stupore e ribrezzo, molte volte avrei voluto dimenticare quello che avevo sentito e tornare alla mia ignoranza di un tempo. Ma anche piangere di gioia per la bellezza di un essere umano è una cosa che mi è capitata spesso.
Sono cresciuta in un paese in cui sin da piccoli ci insegnavano a morire. La morte, ci insegnavano. Ci dicevano che l’essere umano vive per immolarsi, per andare al rogo, per offrirsi in sacrificio. Ci insegnavano ad amare chi porta un’arma. Se fossi cresciuta in un altro paese non avrei percorso questa mia strada. Il male non conosce pietà, contro il male bisogna essere vaccinati. E noi siamo cresciuti fra carnefici e vittime. I nostri genitori vivevano nella paura, non ci raccontavano tutto, e ancora più frequente era che tacessero proprio; ma l’aria stessa che respiravamo era appestata dal male. Il male c’era sempre, non ci perdeva di vista.»
Svetlana Aleksievič, Una battaglia persa.