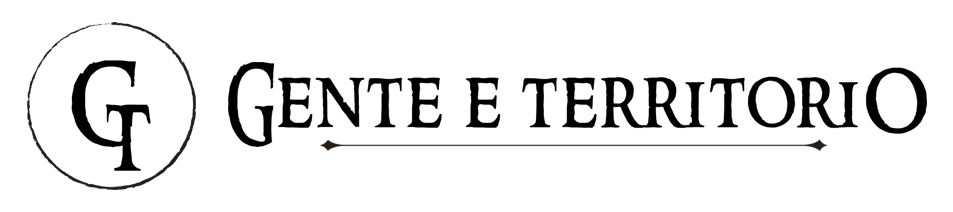L’Autrice, scomparsa da tempo, artista, scrittrice, combattente per la libertà nell’Italia del nord, ultimò queste pagine negli anni ’70 del secolo scorso.
(Segue da: https://www.genteeterritorio.it/la-pioggia-e-il-vento-i/ – https://www.genteeterritorio.it/la-pioggia-e-il-vento-ii/ – https://www.genteeterritorio.it/la-pioggia-e-il-vento-iii/ – https://www.genteeterritorio.it/la-pioggia-e-il-vento-iv/)
Vedi gli acrobati di Picasso, quelli con la scimmia. I piedi della scimmia così dolci a lato di quelli umani che di questi suggeriscono le articolazioni sensibili delle dita dentro le scarpette da ballo. Intorno alla testa del bambino le mani, crisantemi. Il collare dell’uomo disegnato come dita di seta. E sui vasi ellenici, le dita aeree eppur corpose da cui partono linee ideali verso la testa, il piede, la mano dell’altro, come se l’artista avesse usato scientificamente – e fosse dato comune – i gesti sacrali: la imposizione delle mani, la preghiera, la evocazione, tutto il linguaggio di forze centripete e centrifughe che le mani possono disegnare nello spazio.
Vorrei saper rivendicare per la scultura qualcosa della carica di magneti che le mani hanno sul piano grafico, dove stabiliscono la rete dei rapporti fra le figure con rigore ma tematico. Ma forse è impossibile. Data una realtà, pur solo pensiero astratto, vi sono aspetti di essa che emergono in due, altre in tre dimensioni. Certe contaminazioni reciproche non contano; parliamo pure di masse per Giotto e di colore per Bernini, resta che la sostanza di una veste è per l’uno ancora inserita nell’atmosfera come materia cedevole, per l’altro si cristallizza in dato potenziale.
Bisogna andare oltre i bronzi di Moore in cui ogni superficie ha un suo valore di riflessione che la allarga a coinvolgere l’ambiente e insieme chiude altre forme all’infinito, e quello scoprirne qualcuna che egli fa a volte appare un gioco superfluo.
Un bianco mi perseguita, un chiarore di vento. Far scultura di questo.
Il vetro si accende e si fa schermo fra me e la dolce fine di questo giorno d’estate.
Guarda che poi morirai. Ricorda la luce che irraggia sui campi l’idrante nascosto ricamando le foglie di vite.
La gioia mi dà una veste chiara che si apre e grida nel vento e passando le case ne risplendono come a luna piena. Preto mi guarderà ridendo.
L’ultima creatura di poesia, a cui lasciare con una stretta di mano questo bene improbabile che chiamiamo pensiero. Lasciamo i ricordi farsi opale sulla pietà de passato. Prestiamoci qualche volta lo sguardo che avremmo potuto avere l’uno per l’altro se le circostanze fossero state diverse.
Le parole hanno il peso di palloncini colorati, ognuno di noi ne tiene un grappolo come l’omino del Gianicolo, ogni tanto allentiamo il filo ma è una finta., il rosso l’azzurro di una parola recedono subito nel grigio dei visi. Siamo chiusi accuratamente in un gesso di paura.
Curva di sabbia, polso d’acqua marina, innocenza di marmo a seguire col palmo il quieto inguine, sostanza che l’arbitrio della mia presenza non incide. Nulla è fermo a guardia della soglia. Nessun’orma si affonda di me sia pure per poco e solo saperti amare per gioco potrebbe darmi speranza di lasciare un segno a cui ritornare. Eppure gridi. Le mie labbra ascoltano, gli occhi ti toccano con paura di farti male.
Tutti abbiamo nelle mani altre vite che uccidiamo per nutrire il nostro giorno. E cantiamo sulla spalla di cieche vittorie la improbabile felicità.
La pioggia d’agosto sul selciato di Parigi ormai senza ricordi. La luce segreta di un pomeriggio d’inverno per i vicoli del Vomero.
Un vento cattivo e l’Arno che ribolle al Ponte alle Mosse.
Torino crocefissa fra i due fiumi, la gialla periferia invernale che si tinge d’orrore ad ogni allarme ed oltre la neve intatta di Superga, in una buca d’odio, la nostra paura e l’inutile pietà.
Con la mano nei capelli dell’ultima gioia il poeta è morto.
Il mio dio è morto. Giace nella polvere delle sue parole come un gran legno nella rena, non seppellibile.
Levigata dall’indifferenza lascio che la polvere di minuti eventi m’attardi le braccia che egli amava sfiorare. La giada antichissima della pena mi orna la gola.
Perché splendidi ponti nel cielo?
Le nubi come campi o colline, un Monferrato nel cielo.
I fiori di Pesco si aprono indifferenti ai 44 Fahrenheit sul grigiore parallelo delle case fra Hammersmith e Shepherd Bush, traslucidi come fiori di cera.
In quest’ora di tramonto, per strade quiete, quando le nubi lasciano passare appena poca luce rosata, l’aria non trasmette suoni; nulla è di nuovo possibile se non viene la sera.
Forse è vero che solo certe luci possono dare ancora un poco di gioia; un’architettura, un profilo di montagna.
Forse è vero, ma è sempre un’assonanza con antiche esperienze, alchimia di ricordi, immedesimazione con situazioni temporali in ogni passato ed ogni futuro.
Non è la droga che apre le porte della percezione. Un’abitudine di pensiero a volte, che permette inspiegabili incantamenti, e par di vedere la trama delle cose, i capillari della realtà.
Così si tenta l’avventura del creare e ci si ritrova nelle mani sempre un’ombra appena di quello che si è visto e che si voleva gridare, non necessariamente agli altri e nemmeno a sé o ala impensabile divinità, ma solo gridare, perché non si poteva tacere l’aver visto.
Dividersi è un’azione che ha due soggetti, un evento vissuto in comune.
A volte può creare un’onda che vibra per sempre, forse oltre il sempre del nostro tempo. Se porgessimo orecchio potremmo sentirla cantare in altre vite, piano, la nostra divisione, la nostra personale morte comune.
Ho fame ho sete ho sonno.
Quella primavera era spenta in noi prima di nascere, la portavano col suo bianco di barchette di carta, le trombe della banda Marché aux Puces, i capelli del sole sulla Senna. Una primavera bambina, nessuna fu mai così bella che fu solo pensata.
(fine)