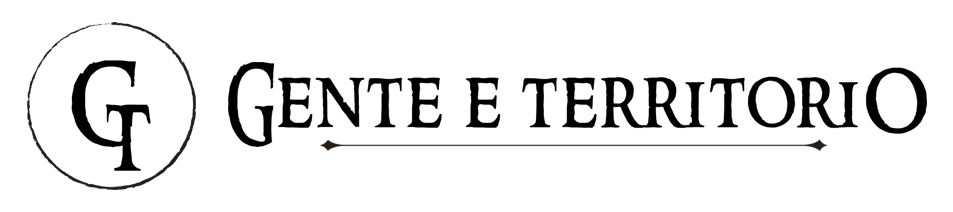L’Autrice, scomparsa da tempo, artista, scrittrice, combattente per la libertà nell’Italia del nord, ultimò queste pagine negli anni ’70 del secolo scorso.
(Segue da: https://www.genteeterritorio.it/la-pioggia-e-il-vento-i/)
Voglio vederlo e non posso.
Non tacere troppo a lungo, il tuo silenzio modella anche te figura mitica, ed io ho bisogno di sentire dove cadono le mie parole, il tonfo lontano di piccola pietra della parola giusta ogni tanto fra tante.
Diceva che devo avere pazienza. Pazienza di che, della sorte mia della sua o di quella di tutti?
Fra noi quattro forse solo tu, insieme mite e violento, sei compiuto, non inconscio elemento catalizzatore.
Mi piace illudermi che un giorno potrò comprare un casolare a Finistère.
Al centro del cortile di Castel Capuano c’è un bambino con un cappotto rosa corto ed un passamontagna malmesso. L’alibi di una divisione, il testimone di un reato, il non-lasciato-a-casa-che-nessuno-lo-guarda? Quanto più il suo sguardo si fa smarrito tanto più noi inutili corifei indietreggiamo ad imbrattare di noi le vecchie mura.
Napoli polverosa, le case scialbe tessere pigiate in un fondo di argilla rosa. Gli odiosi cipressi di Poggioreale che seghettano il cielo, dichiaratamente verdi e compresi di sé. Il cielo di cristallo verde.
Questa è l’unica cosa rimasta fra noi, che non avremo mai pietà l’uno dell’altro. Il che vien detto nobile, per quel che è nobiltà.
Il vento disegna le nuvole sempre più in fretta. Dietro la nera ringhiera liberty del balcone il mare striscia color di piombo dove il vento attinge sfilacci frettolosi che manda ad orlarsi di luce in alto. Sopra Castel dell’Ovo una nube prende la forma di un angelo col braccio levato, un San Michele he esita fra severità gotica e tenerezza da presepe; poi si accende nei contorni e diventa un’aquila che perde penne nel mare.
Una città smemorante di fragili rovine, ed uomini come erba. Lo scirocco muove una polvere aspra e la gonfia alta sui Granili.
Navigano lentamente bianchi bastimenti nel sole.
Eravamo seduti dentro l’aiuola sotto la statua di Leonardo, e guardavamo l’erba dove si perdevano piccole gocce di pioggia. C’erano parole ma non erano niente appena puntelli messi qua e là a tener fermo il momento, a renderlo visibile. A Fiumicino le barche e le gru erano tutte di un azzurro slavato e rugginose, il mare mandava odore di fogna. Dal pergolato cadevano giù – e ne ridevamo – grosse formiche con le ali.
Il bisogno di stringersi subito chiusa la porta, la valigia a piedi, e il ritrarsi, il prender tempo; avevamo appena uno spiraglio sull’altro e ci comportavamo come se – divelti i battenti – già potessimo vedere il pensiero non nato. Ancor oggi, ogni volta che mi accade di d’essere sveglia all’alba, quando si sentono solo gli uccelli, rivedo l’Acropoli alta sulla lebbra delle case aggrappate alla collina, rosa azzurra e distorta come la rese poi il teleobiettivo, immagine del mito che inseguivamo.
E tutto bruciato subito, e la fatica dopo di ricomporre i silenzi, di ritrovare la forza dei piccolissimi gesti.
Dietro il promontorio di Sounion il telo grigio dell’Egeo. Pioveva, l’odore del mare giocava fra una colonna e l’altra, passava corposo fra le gocce, ma appena si voleva accoglierlo ci si trovava pieni solo di un molle fiato di pioggia. Si camminava su un marmo coperto di piccolissimi fiori cedevoli e scivolosi come muschio, un marmo che sembrava avesse voluto generare in un bisogno di mostrarsi vivo in maniera diversa dall’abituale esser vivi della pietra. Non avevamo più ansia di domande, contava solo la pioggia, il tempio rosa, il mare.
“Che cos’è uomini che volete ottenere l’uno dall’altro?” Erano state confuse le quinte, attingevamo ad un altro repertorio, il sangue seguiva altri segni ed ogni cosa prendeva già il fradicio sentore della fraternità di pensiero.
Da come si allargava su Glifaia uno spazio di luce si capiva che sarebbe venuto il vento. Ne avevamo ormai la polvere fra i denti.
Gridare un nome, gettarlo in lettere sparse come traccianti da una trincea e attendere che ricada a fiorire di primule il filo spinato.
Non so se ci rese accorti la cadenza dei silenzi o l’esitare degli sguardi o lo stupito indietreggiare degli altri in dimensione d’ombre. Le parole divennero mani tese: urtavano ai margini della realtà rifluivano incerte cadevano in un silenzio a riempirlo d’echi segnavano lo spazio come gesti. E poi ciascuno vide negli occhi dell’altro un così estremo consenso che seppe solo voltarsi a cercare compagnia dombre.
Jean ma che faccio a trascinarmi ancora al limite del proscenio a spiare la sala? E le parole sonanti. Quanto sono più significanti di quelle legate a caso?
Ho paura e non so più di che.
Forse che qualcosa resterà del nostro lungo parlare, le parole si intrecciano ancora nello spazio da qualche parte e creano altre parole, e cadranno un giorno, non su di noi ma cadranno, come quei semi di primavera che s’interrano nella connessura di un legno alla finestra e ne trovi un mattino il filo d’erba?
Quel pomeriggio a Parigi non riuscivo a far altro che star seduta a guardar la porta chiedendomi se avrebbe dovuto o no chinar la testa per entrare. E chiedendomelo continuamente, continuamente anche mi figuravo il momento in cui avrebbe aperto la porta e l’avrei visto lì, con intorno agli occhi le rughe a raggiera di una risata trattenuta. Non ricordo quando la gioia si mutò in attesa e in dubbio e incominciò il dolore. A sera la cosa impensabile era avvenuta, riempiva la stanza della sua vita mostruosa, mi pesava addosso da ogni parte, si insinuava dentro di me con l’aria che respiravo: era stato a Parigi e non mi aveva cercato.
Ma c’eravamo pur parlati ieri a lungo, avevamo pur riso di noi, e da quanto avevo solo la voce, questa realtà poco credibile che mi arrivava dopo esser stata sembrata e ricomposta, che c’era da temere quasi che lo spazio sottraesse ogni volta qualcosa, una inflessione, una pausa, magari chissà addirittura una parla, la più significativa.
Era come certi pomeriggi a Torino quando aspettavo mio padre per la passeggiata domenicale. Ero vestita con cura, i capelli tirati in una sola treccia, e non giocavo per timore di gualcire le pieghe della gonna. Non mi restava altro che star ritta dietro i vetri del balcone ad aspettare. E lui non veniva, se n’era dimenticato, aveva voluto restare con l’amica, o chissà dove. Si faceva tardi, mi dicevano “vieni, togliti il vestito”, ma io non volevo, come se togliendomelo si cancellasse il fatto stesso che era pur domenica e il giorno che mio padre doveva stare con me. Alla fine mi spogliavano in piedi come una bambola davanti al balcone, e non ho mai dimenticato il breve tempo che restavo in sottoveste, mentre mi scioglievano i capelli, a guardare i lampioni che si accendevano in via Fréjus e sentivo la stanchezza diventare sonno. Le labbra erano salate come ai giorni del mare.
Bisogna rifiutare l’inganno delle colorate speranze che fa schermo alla morte e le permette di nutrirsi di noi di giorno in giorno, così che arrivata a sazietà neppure lei vedremo, neanche il tempo di scoprirci senza suono.
(continua)