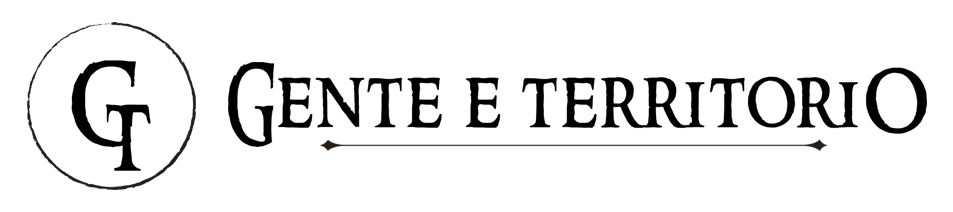L’Autrice, scomparsa da tempo, artista, scrittrice, combattente per la libertà nell’Italia del nord, ultimò queste pagine negli anni ’70 del secolo scorso.
Dieppe. A prua una bandiera rattoppata tenta di prendere il vento, ricade. Fra le nubi ali immobili. Si potrebbe tutti se si volesse, le braccia ferme.
Che ho fatto per meritare questa bellezza? C’è un premio per la fuga e il tradimento?
Ho tre anni. Da un balcone attraverso una ringhiera barocca guardo giù nella strada dove i tram corrono come millepiedi. Alle spalle sta l’ombra della stanza dove la nonna cammina adagio da una parte all’altra recitando il rosario.
Ascolto il buio della casa che cresce. So tutto del balcone, l’allegria della piastrella nuova, l’immusonita malagrazia di quelle vecchie che nulla riesce a far splendere, dispettose come finti amici brillano sotto l’acqua e subito si fanno più smorte di prima.
So il segno chiaro fra la soglia della cucina e la misteriosa apertura a battente che ingoia le cose che vorrei conservare sbuffando su un odore acre. Nel cortile un’erba gialliccia disegna il piede dei muri e il contorno dei tombini.
Quando mia madre torna da scuola viene acceso il lume a petrolio sul tavolo di cucina.
Posa borsa e quaderni sempre con lo stesso gesto e lavora piano intorno allo stoppino. Mi porta matite colorate.
A volte in estate andiamo nel grande prato davanti a casa, un prato di periferia con erbe che somigliano a spighe di grano, trifoglio dai fiori viola e fiordalisi. E c’è la menta che si può stringere nella mano finché l’odore entra nella pelle ed alla notte fa compagnia. Lei cammina con un libro nelle mani da cui non legge mai; la seguo pensando a case meravigliose con decine di lumi a petrolio e tendine arancione ad ogni finestra.
A via Fréjus tutto è nuovo, in cucina c’è una stufa tonda di ghisa davanti a una montagna di fascine e di pezzi di legno. C’è una cassa di carbone. Sopra i cerchi della stufa si mettono le castagne e sotto, dove si raccoglie la cenere, le patate. Rami ancora verdi asciugano lentamente e trasudano linfa come gemme.
I ceppi bisogna spaccarli perché entrino nella stufa, mia madre lo sa fare ma sembra che non abbia mai forza abbastanza, io vorrei provare ma so che è inutile chiederlo, e mio padre ride, senza neanche alzar la testa dalle carte. Ed alla fine ride anche lei, prende la piccola accetta con quel suo respiro corto di quando sale le scale e gli occhi le diventano come braci di coke.
Schiaroglio. Lasciami ricordare Jean.
Nella valle il Ribordone rumoroso fra i sassi. La montagna dorata di nocciòli, i frutti così difficili da prendere, le mani graffiate.
I rami si attorcono come capelli su un cielo logoro di voli. Gli uccelli riposano ad ali aperte.
Sulla neve i sogni anneriscono come frutti tagliati.
Il treno corre per Londra fra campi di fiori gialli. Piove.
Ricordi la piazza di Trieste? Gli steli neri dei lampioni, le statue aggrappate ai cornicioni come pronte a volare.
Eravamo stanchi, camminavamo piano, parte del quadro, simili alle figure di certi paesaggi veneziani che non sai bene se è un uomo sulla riva o un paletto o un rivolo d’ombra che sottolinea una luce.
Mancava lo spazio intorno per compier gesti.
L’antica paura di essere respinti, voglia forse di serbarsi a sé soli, stava già mutando la stanchezza in noia dell’uno per l’altro. L’unica cosa che riuscivamo ad offrirci erano tenui sorrisi.
Ad Aviano i prigionieri erano loro, quelli che stringevano il cerchio con sguardi assetati non potendo entrare nel girotondo.
Il legno il pane il miele gli altri e la foresta.
Correndo sulla lama del coltello un moscerino mi assorda. Mi assorda la realtà che mi fingo di un tuo sguardo.
Così vado da un traguardo illusorio ad un altro che lo è ancor più, incapace di intraprendere qualcosa che duri – e durare perché – per umiltà o solo per impotenza. Mi pare arroganza dire che è questo che voglio fare, che farò, dirlo facendo calcoli oltre un mese, o sia pure oltre un giorno.
Ci si ingoffa in un abito comune, si tenta di essere come tutti, disperati di sapersi e non sapersi diversi, e si è tanto come tutti volutamente che alla fine si è diversi solo per questo accanimento.
Lo specchio rende ogni giorno una immagine un po’ più sbiadita, le borse sotto agli occhi più scure, quella macchia di sole sulla guancia che è diventata un segno nero, un melanoma magari; paura e sollievo perché forse è finita, si può riprendere il mitra e sparare ai comignoli dentro il sonno della morfina.
Quando le colline del Monferrato fiorivano di falò e i bambini correvano per la provinciale con pistole nelle tasche del cappotto.
Di notte la vallata verso Pino era una fossa nera che odorava di resina. Quando pioveva mi fermavo sotto i castagni, pensavo di farmi un mantello di fili di pioggia; e sarei passata con uno sbuffo di gocce sotto il naso delle S.S.
Nella stanza dal soffitto alto dove il fumo del camino premeva come una nube gli uomini ridevano e cantavano, a volte tacevano aspettando. Nessuno si occupava di me, stavo composta in un angolo come un robot disattivato. Guardavo i piccoli ragni bianchi che correvano sulla parete, la luna seduta sui comignoli, il fuoco. Aspettavo.
La stanza rotonda della torre aveva pannocchie di granoturco rosso ai muri e a terra un tappeto di ranette sulla paglia. Il grande letto barocco aveva una coperta di broccato. Sotto le gaggie il fossato era tutto di argilla azzurra.
Soglio le notti dei lanci, le voci, i fuochi. Il ritorno sopra il carro delle armi dove il fieno sentiva più forte che nei campi. Lo zoccolìo lento del cavallo bianco.
A marzo gli alberi fioriti di bruchi gemevano nel sole.
E tutti quegli occhi fissi a far specchio alle felci.
Dopo anni Jean il Monferrato era un muro di nebbia su campi incolori, e noi a guardare i sogni traditi, formiche da sempre sulla stessa strada. Ad ogni curva dalla neve sterpi come croci.
(continua)