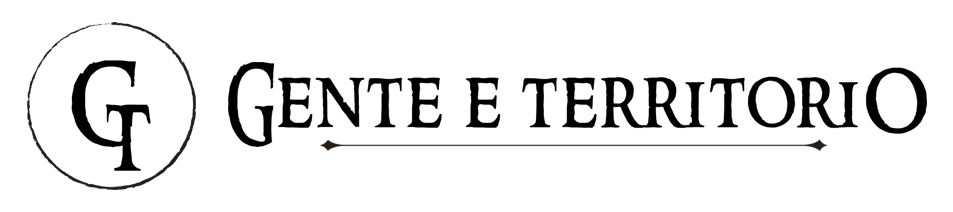Goffredo Fofi è un intellettuale “militante” che ha accompagnato le vicende sociali e culturali per tutto il secolo scorso fino a oggi. Qui spiega le ragioni di una scelta: leggere al Salone del libro di Torino un lungo racconto di James Joyce che chiude la raccolta dei “Dublinesi”, tradotta spesso come “Gente di Dublino” (1907). Ha per titolo “I morti” (“The Dead”), e qualche lettore ricorderà il capolavoro, il suo ultimo film, che ne trasse il regista di origine irlandese John Huston.
«In un salone del libro di Torino, mi venne chiesto qualche anno addietro di leggere un romanzo (per brani, nel tempo di un’ora) che era stato molto importante per la mia formazione, per la mia storia di lettore. (…) Scelsi “I morti” di Joyce e vorrei che tutti lo leggessero o rileggessero perché la parte finale del racconto, di straordinaria serenità e bellezza, canta il destino comune, canta la neve che scende su campagne e città dell’Irlanda e scende sui vivi e scende sui morti, nella piena coscienza che i vivi li raggiungeranno. I morti non muoiono, sono qui tra noi anche se tendiamo a dimenticarli per la paura di doverli presto raggiungere. La mia nonna materna andava per lavori in campagne lontane e tornava spesso nella notte dopo lunghe fatiche pagate in natura, e quando le chiesi se non avesse paura, mi disse tranquillamente che no, perché lei parlava con i morti, perché nella notte l’accompagnavano i morti.
Fu Menandro a scrivere che “muore giovane colui che gli dèi amano”, e fu Leopardi a ripetere che “muore giovane colui che al cielo è caro”. Tutto sta nel credere nell’esistenza degli dèi o di un Dio unico e onnipossente; tutto sta nel credere in un aldilà in cui la sorte dei giusti possa essere diversa da quella dei malvagi. E tuttavia, anche per un non credente, può essere di consolazione pensare che gli dèi (o Dio) vogliano accanto a sé quei giovani che essi hanno amato, dei quali hanno apprezzato il valore la generosità la bellezza, quei giovani che hanno avuto ai loro occhi qualità o meriti speciali; e dei quali noi, i terrestri, i vicini, gli amici e diciamo pure i compagni, abbiamo goduto la vicinanza e la confidenza, la comunione delle idee nonché degli affetti.
È stato forse l’Ecclesiaste ad avere scritto che se c’è un aldilà dove la condizione dei buoni è diversa da quella dei cattivi, solo allora la morte non può gridare la sua vittoria, non può affermare che il suo potere è infinito. È quest’illusione a permetterci tuttavia di pensare che non tutto è stato inutile nel mondo che abbiamo conosciuto, negli anni che abbiamo vissuto, in quel poco che siamo riusciti a fare dalla parte del giusto e del vero e, soprattutto, a riscattarci – la convinzione per cui, quale che sia stata l’epoca che abbiamo vissuto e in cui abbiamo conosciuto tanti “cari agli dèi” prematuramente strappati alla vita, qualcosa di buono e di bene intenzionato tuttavia l’abbiamo fatto, e qualche risultato abbiamo ottenuto anche se fragile e di breve durata. Attraversando gli aspetti più amabili come i più detestabili della nostra società, fondamentalmente accettandola più che non osteggiandola. Quali che siano state le nostre consolazioni e le nostre ipocrisie individuali o collettive, quali gli immani egoismi e le fragili generosità, quali le perfidie personali o di gruppo, di casta o di fede, di classe o di nazione, o al contrario le rare ma piene tenerezze. Quale che sia stato il nostro accettare o al contrario il non accettare “lo stato delle cose” da lungo tempo consolidato, e le sue novità di superficie oppure, al contrario, quelle più nascostamente o più vistosamente radicali.»
Goffredo Fofi, Cari agli dèi.