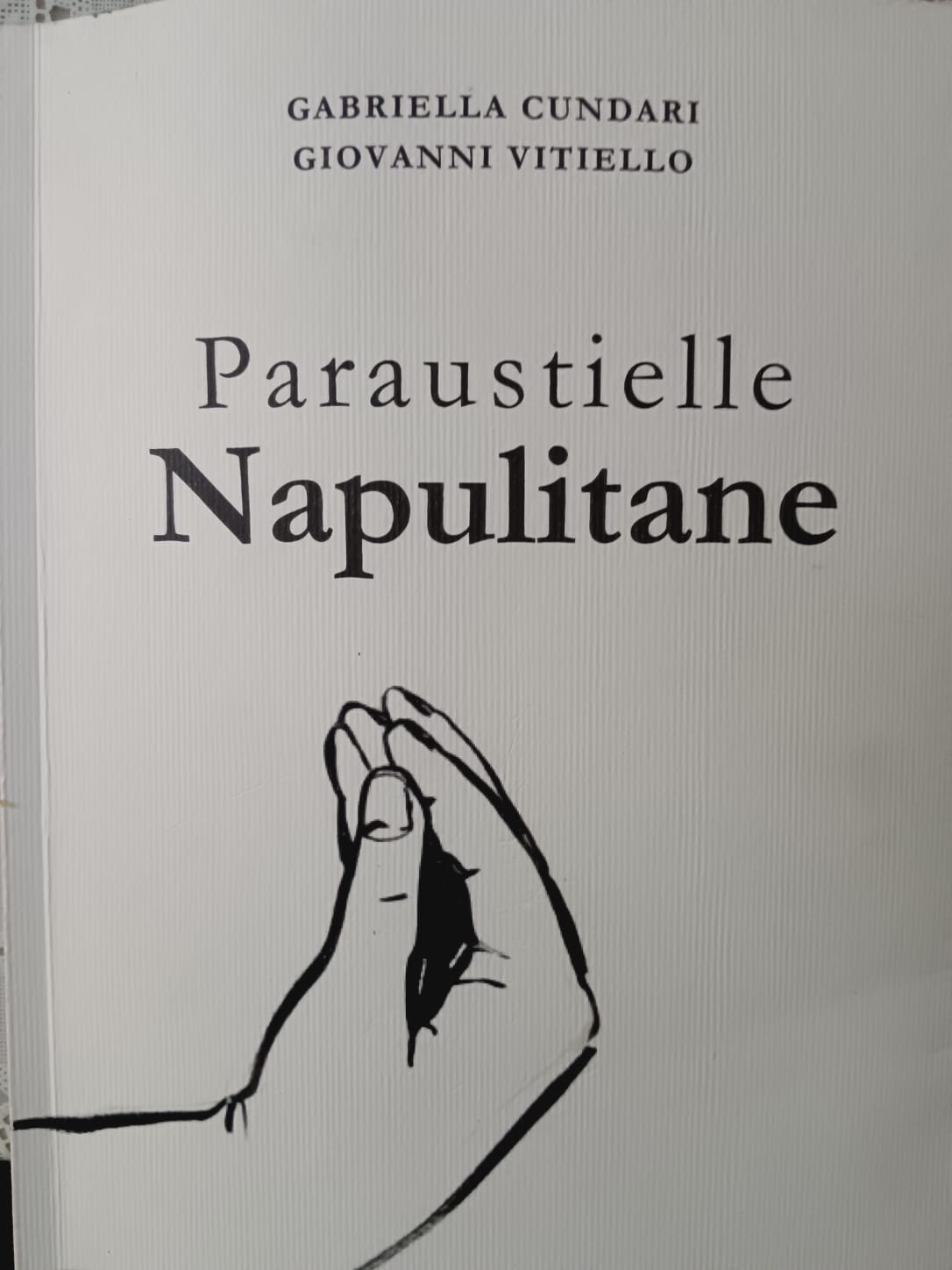Gabriella Cundari e Giovanni Vitiello raccontano con fatti, detti, atmosfere l’essenza dello spirito e dell’essere partenopei nel libro “Paraustielle napulitane”.
La tecnica utilizzata è quella del racconto attorno a temi che caratterizzano l’essenza dei comportamenti e delle culture che hanno nutrito la terra del Vesuvio.
Il ricorso ai proverbi napoletani, utilizzati nel corso della narrazione, consente di sintetizzare in poche parole il contenuto di quella capacità di integrazione e di assimilazione che caratterizza un’antica tradizione capace di una resilienza ante litteram.
La religione, per tutti i popoli, costituisce la memoria della sfera del sacro che diventa anche profano. I cimiteri della città sono luoghi che trasmettono quel connubio tra superstizione e civiltà che si mescola nel lungo itinerario della storia partenopea.
Il Cimitero delle Fontanelle raccoglie circa 40.000 teschi di persone morte durante la peste del 1656 ed il colera del 1836. L’usanza dei napoletani era quella di adottare una delle capuzzelle facendone il proprio ponte verso l’aldilà.
Di converso, il Cimitero delle 366 fosse, progettato dal grande architetto Ferdinando Fuga, è stato il primo cimitero per il popolo, con una anticipazione di circa quaranta anni rispetto alla riforma napoleonica.
Sul Santo protettore, Napoli non ha lesinato fuochi di artificio: ne sono stati nominati tra il Seicento ed il Novecento ben cinquantuno. Poi, con la riforma liturgica del 1973 ne vennero riconosciuti solo tre: Santa Patrizia, San Severo e San Gennaro, divenuto poi con il tempo il Santo Patrono preminente.
Il popolo napoletano, soprattutto quello di un tempo, ha fatto della religione il suo parafulmine. I cittadini hanno per lungo periodo affidato al divino ed ai santi il proprio destino, convinti che “Mamma m’ha fatto e Ddio ‘nce penza’. In fondo questa mentalità ha lasciato le sue tracce in molti detti popolari: “Assafaddio”, “Chello ca fa Dio, è tutto buono”.
La stessa morte è un passaggio che si traduce in una declinazione che connota le caratteristiche di un popolo. Il becchino a Napoli è lo “schiattamuorto”. Morte e vita convivono nella cultura napoletana come momenti inscindibili.
Teatro e musica sino due altri pilastri attorno ai quali la cultura partenopea ha contribuito a forgiare il carattere ed il destino di questa comunità, anche in rapporto con gli altri territori. I grandi autori ed interpreti del teatro napoletano, da Scarpetta a Eduardo, da Totò a Tina Pica, non solo hanno introdotto figure, stili, filoni che hanno inciso sulla storia della città, ma hanno incorporato nel loro mestiere l’accumulazione culturale della tradizione.
Quanto alla canzone napoletana, conosciuta e rinomata in tutto il mondo, basta dire che il solo museo che la celebra sta, dal 2004, a Tokio. Ovviamente, tra i 200 cimeli, c’è lo spartito originale di “O Sole mio”, canzone suonata alle Olimpiadi di Anversa al posto dell’inno nazionale italiano, il cui spartito era andato smarrito.
Canzoni e calcio si incrociano nella storia della città, quando il 7 dicembre del 1975 allo stadio Olimpico il Napoli sconfigge la Lazio e balza in testa alla classifica. Dal settore dei tifosi partenopei improvvisamente, all’unisono, si intonano le parole di “O surdato ‘nnammurato”, destinato poi a diventare l’inno della squadra azzurra.
Gli autori di questa miniera di napoletanità ci offrono nel loro volume un campionario davvero molto ricco delle storie e delle abitudini della città partenopea. Mi piace chiudere con un altro episodio legato alla figura dello storico attaccante del Napoli Attila Sallustio.
Con la sua lussuosa vettura, una Fiat 508 Balilla, investì un passante in Via Roma (o via Toledo). Il malcapitato, dopo averlo riconosciuto, esclamò: “scusate tanto, è colpa mia. Voi potete fare tutto quello che volete”. In tema di rapporto con un mito incarnato nel pallone e con l’autorità riconosciuta dai napoletani non c’è molto da aggiungere.