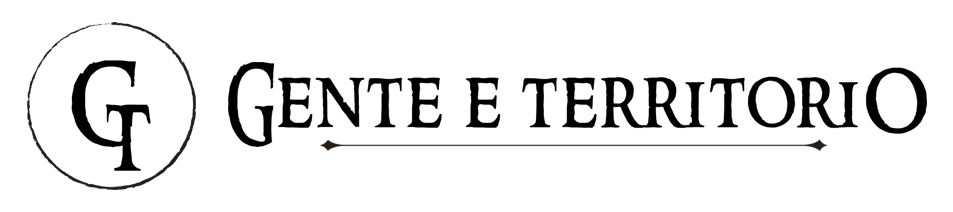Ci sono diversi modi di calciare le punizioni.
C’è il classico tiro a giro, quello che fanno i fuoriclasse che giocano sulla trequarti. Si pensi ai tiri di Messi, o ancora più a quelli di Diego, ma anche di altri. Si tratta di un calcio di punizione quasi sempre da una posizione abbastanza vicina alla porta, con la palla che, accarezzata, aggira flessuosa la barriera e beffa il portiere. Memorabile quella di Maradona alla Juve, calciata in seconda, sul passaggio di Pecci, da una distanza così breve ritenuta scientificamente impossibile.
C’è poi la punizione secca, violenta, più di potenza. E’ il modo di calciarle di Ronaldo, anche da molto lontano. La punizione da grande distanza era anche la specialità del terzino brasiliano Roberto Carlos. I suoi erano missili terra aria non gioco del calcio.
E una variante della carezza dei fuoriclasse, ancora più specifica, fu anche la “foglia morta” di Corso, sregolata e irregolare ala sinistra della grande Inter di Moratti ed Herrera.
Pensavamo di averle viste tutte ma quando arrivò da noi quello strano giocatore serbo scoprimmo un calcio di punizione mai visto prima. Sinisa Mihajlovic aveva un modo di tirare le punizioni che un po’ corrispondevano al suo carattere. Agro e dolce insieme. Il suo era un tiro “lungo”, calciato quasi sempre da distanze impossibili. Ma la sua traiettoria più che potente disegnava quasi come l’immagine di una pianta rampicante. Si inarcava non troppo alta, fendeva l’aria dando l’idea di un lungo ma implacabile percorso, soffice nel suo procedere. Quasi poetico. C’era dentro quel tiro insieme potenza e carezza, spesso una carezza lunghissima come fosse la nostalgia di qualcosa.
Da cose brutte arrivava Sinisa, la sua terra disgregata e divisa, le durezze e le sofferenze di guerre e di lotte tribali. Nel suo sguardo agro dolce, come nelle sue punizioni, si leggeva un po’ tutto questo. Anche nelle sue contraddizioni. Da uomo giusto quale era forse non avrebbe dovuto essere così solidale con alcuni leader. Eppure, forse proprio un certo suo senso della lealtà e dell’onore, insieme alla tragedia dei conflitti, lo spinsero a restar sempre dalla sua parte, laddove soffrivano familiari ed amici.
Sincero era sincero Sinisa. Lo disse più volte che senza il calcio sarebbe diventato un uomo perduto. E restò aggrappato a quelle sue punizioni. E’ stato anomalo da calciatore e da tecnico. Ben piantato ma non aggressivo, tiro potente ma traiettoria così lunga che doveva nel percorso per forza addolcirsi. Anche da allenatore, burbero, deciso, ma mai sergente di ferro. Ed era raro vederlo agitarsi troppo impartendo istruzioni dai bordi del campo.
Con la malattia, aggressiva, cattiva, aveva ingaggiato, infine, la sua lotta più aspra. Questo è bastato a tanti per definirlo guerriero. Sinisa, però, guerriero in fondo non lo è mai stato. I suoi occhi erano dolci, acuti ma dolci. Di quella tenerezza aspra di chi ne ha viste e sofferte tante. Per questo dava poco peso in fondo ai fatti di calcio. Era la sua vita ma sapeva che il peso dell’esistenza sta altrove. Chi lavora dalle cinque di mattina alla sera, non voi, può lamentarsi, diceva ai suoi ragazzi. “Il nostro non è lavoro ma un privilegio, perdipiù milionario”. La vita grama degli inizi gli era rimasta stampata nel petto.
Sembrò incredulo ai primi segni della malattia, seppe gestirne il peso con leggerezza e consapevolezza. Lottava, certo, ma con lo sguardo insieme mite e fiero del poeta di strada. Schiaffo e carezza come il suo calcio di punizione.
Non ce l’ha fatta. Ma non ti preoccupare Sinisa, la tua lezione – ai ragazzi in campo e a tutti noi – è arrivata lo stesso.